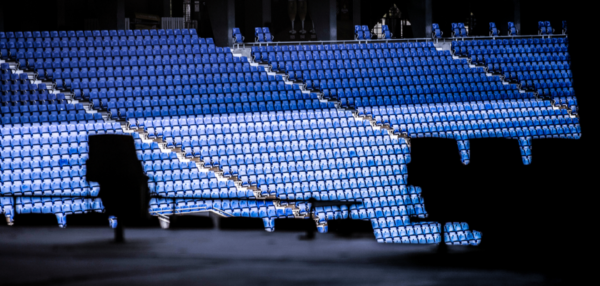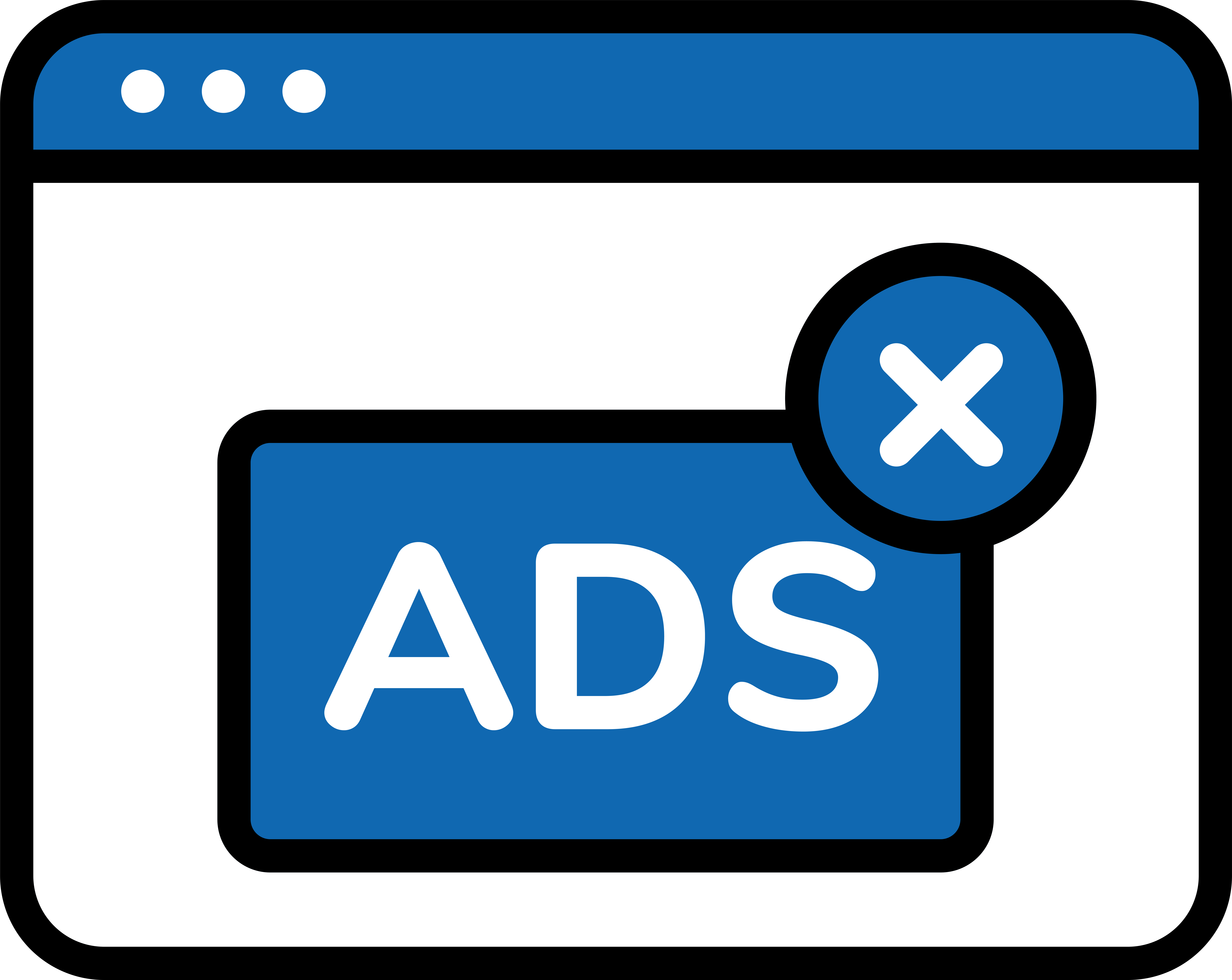Da dieci mesi ogni volta che vedo una bella partita di calcio non riesco a non pensare a quanto sarebbe stato meglio con il pubblico. Limitandomi a questo fine settimana: prima ho visto la Salernitana (terza in classifica di Serie B) segnare al 92esimo il gol del 1-1 nella partita col Venezia (quarta in classifica), e due minuti dopo segnare quello del 2-1 che ha chiuso la partita; poco più tardi ho visto il Cagliari rimontare il Parma, in una partita in cui era stato sotto 0-1 e 1-3 segnando il gol del 3-3 al 91esimo e quello del 4-3 al 93esimo (un vittoria che è servita al Cagliari giusto per sperare di non retrocedere, accorciando a 5 punti la distanza dal quartultimo posto e mandando di fatto il Parma in B). È anche questo il meglio di quello che può offrire una partita di calcio, giusto? Eppure non ho potuto fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato meglio con il pubblico. Cosa sarebbe successo all’Arechi al secondo gol di Gondo? Come avrebbe reagito la Sardegna Arena nei secondi precedenti quello di Alberto Cerri? In tempi normali davanti a partite del genere, giocate in stadi lontani, mi chiedo cosa proverei ad essere lì, da un anno mi chiedo cosa proverebbe un essere umano qualsiasi lì presente, a fare l’unica cosa che la maggior parte di noi può fare: lo spettatore, il testimone di un evento eccezionale, sentendosi però anche coinvolto in un rito collettivo. E mentre facevo queste riflessioni, da qualche altra parte di questo stesso multiverso pandemico, c’era chi pensava cose opposte: Siamo sicuri che il calcio abbia bisogno di questo tipo di partite? E dei tifosi?
Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno dato una prospettiva meno personale e intima all’angoscia che ormai mi creano gli stadi vuoti. La mia è una sensazione che è cresciuta col passare del tempo. Ovviamente all’inizio ero soprattutto contento che fossero tornati a giocare: i palloni sanificati, i saluti coi pugnetti, le esultanze senza contatto e l’invito a ridurre i contatti su calcio d’angolo: l’assenza di pubblico era uno dei tanti compromessi che abbiamo dovuto accettare purché si tornasse a giocare. Certo sarebbe stato meglio se… pensavo, ma è già tanto che si giochi. Oggi però sono soprattutto angosciato ogni volta che l’inquadratura della telecamera si allarga dal campo agli spalti vuoti; ogni volta che mi rendo conto, come se fosse la prima volta, che quelle che sto sentendo sono le voci dei giocatori in campo e delle panchine. Sono grida diverse da quelle di sessanta o anche solo diecimila persone tutte insieme. Più distinte le une dalle altre e al tempo stesso sembrano più chiare e specifiche nel loro significato, mi arriva la competitività dei calciatori, la loro carica agonistica individuale, che è sostanzialmente diversa dal ruggito indistinto del pubblico. Finalmente capisco cosa intendevano i miei nonni quell’unica volta in cui sono venuti a vedermi giocare e dopo la partita mi hanno detto solo: «La prendi troppo sul serio questa cosa». I calciatori professionisti mi sembrano esageratamente coinvolti. Ma è solo perché non c’è nessun altro tranne loro, con il pubblico è scomparsa la componente rituale di tutta la faccenda e sono rimasti gli unici a esprimere le proprie emozioni, nel vuoto pneumatico di arene giganti che sembrano l’interno di relitti alieni.
Ecco cosa intendo veramente: sento che niente di positivo può succedere in uno stadio vuoto. Mi sembrano luoghi in cui si possono solo torturare i prigionieri, come a Santiago del Cile, o costruire tendopoli in caso di terremoto. In Call of Duty Warzone, un videogioco di guerra dall’ambientazione iperrealista e oscura (tirato curiosamente in ballo da Andrea Agnelli come competitor del calcio giocato) lo stadio è uno dei luoghi più sinistri di tutta l’ambientazione, circondato da strade larghe e vuote prese di mira dai cecchini, in cui non puoi fare a meno di sentirti in pericolo, in cui da un momento all’altro sarai vittima di un’imboscata. E questo vale anche per gli stadi migliori. Sapete a cosa assomigliava il Parc de Princes la settimana scorsa, con quella strana coreografia lucida? Alla pancia di un rettile gigante, o di una balena. I calciatori di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, d’altra parte, erano piccoli come quelli del Subbuteo, davano voglia di mettere le mani nello schermo e muoverli con delle schicchere. E la settimana ancora precedente, durante la partita di andata, l’Allianz Arena di Monaco con la sua austerità e un’orizzontalità più pronunciata, immersa com’era in una nebbia nevosa, era sembrata una gigantesca porta-aerei vista dall’acqua. Poi è scesa la neve vera e propria e sembrava una partita giocata nell’emisfero opposto a quello in cui è girato Blade Runner 2049, ma in quello stesso mondo, non in questo. Mai come quella notte Leroy Sané è sembrato solo un ragazzo in conflitto col proprio destino, che è quello di avere il talento per poter dribblare chiunque vuole, quando vuole, senza sapere però cosa fare immediatamente dopo.
C’è una sproporzione troppo grande tra la funzione che questi stadi dovrebbero avere e la realtà del calcio durante il Covid. Questa forse è la ragione per cui ho sempre trovato scomodi, in qualche modo faticosi, i concerti nei grandi stadi. Nessun uomo da solo, per quanto eccezionale, è fatto per avere quel tipo di scenografia intorno. Adesso posso dire di pensare lo stesso per un gruppo ristretto di uomini. I più grandi calciatori al mondo, macchine biologiche uniche, con un talento preternaturale, divino, calato dall’alto, nutriti col cibo migliore, massaggiati dalle mani migliori, allenati coi programmi migliori, rimpiccioliti all’istante da un invisibile raggio laser. L’effetto è simile a quello che si ha incontrando una grande star, un attore molto bello che hai visto per anni su schermi e pagine stampate e che di persona si rivela più piccolo di quello che immaginavi, facendoti spontaneamente pensare: possibile sia tutto qui?

Gli stadi senza pubblico al loro interno si trasformano immediatamente in reperti archeologici. È come se quella parte della città in cui viviamo, a noi contemporanea, venisse scagliata indietro (o forse in avanti) in un era senza umanità, azzerando ogni distanza che la separa dal Colosseo e dal Circo Massimo. Se, mettiamo, si continuasse in eterno ad escludere il pubblico dagli stadi un giorno mi troverò a raccontare a mia figlia cosa succedeva là dentro esattamente come dovrò raccontarle che a piazza Navona un tempo venivano chiuse le uscite per riempirla d’acqua e fare battaglie navali. Un pezzo della civiltà in cui sono cresciuto, per quanto possa essere insignificante per alcuni, per carità, sparirebbe nel nulla. Nessuno proverebbe più la sensazione che ho provato io – e molti come me, prima e dopo di me – la prima volta che salendo le scale dello Stadio Olimpico ho visto il manto verde (questo, invece, più verde di come mi aspettavo) affiorare dietro l’ultimo gradino (era un Roma-Cesena inutile dei primi anni Novanta o della fine di quelli Ottanta, un’altra partita che qualcuno giudicherebbe senza nessun valore). Nessuno saprebbe cosa significa vivere un evento così coinvolgente circondato da estranei, con sconosciuti vicini, troppo vicini, invadenti magari, con la punta dei piedi sulla tua schiena, i gomiti larghi, la voce troppo forte e opinioni di cui faresti a meno. Eppure questo è stato, finora, e quanto meno per la maggior parte del tempo in cui è esistito, guardare una partita di calcio.
Forse il fatto che nessuno, tranne il Real Madrid, abbia pensato di spostarsi da qualche altra parte, dimostra che la nostra immaginazione è limitata di fronte agli imprevisti di questa portata. Che come specie tendiamo quanto più possibile a fare le stesse cose che siamo abituati a fare. E l’altro lato di questa medaglia è che ci adattiamo e abituiamo a tutto: magari sarà strano quando gli stadi saranno di nuovo pieni; magari condividere lo spazio e l’aria, entrare in contatto con perfetti sconosciuti, con i loro possibili virus, non sarà naturale come era prima. Il Madrid gioca abitualmente nel suo centro di allenamento di Valdebebas, nello stadio intitolato ad Alfredo Di Stefano, con sullo sfondo le luci di case piccole come quelle dei presepi. Klopp ha detto che è stato «strano» giocarci, ma Anfield Road senza pubblico sembra un campo da calcio circondati dai muri rossi di un gigante Pronto Soccorso. E perché, invece, il Real Madrid ha scelto di non giocare nel Santiago Bernabeu vuoto? La ragione razionale è che approfittando dell’interruzione del 2020 dovuta alla prima emergenza Covid abbiano anticipato dei lavori di ristrutturazione (ed è di certo conveniente avere un terreno pronto e perfetto come quello del Di Stefano, anche se in dieci mesi le squadre che avessero voluto spostarsi avrebbero senza dubbio fatto in tempo ad attrezzarsi), ma nulla toglie che ci siano ragioni più profonde. E cioè che qualcuno abbia preferito un’atmosfera da allenamento all’angoscia che striscia nelle gradinate vuote e fredde e che mette a disagio noi che guardiamo quanto i calciatori. Messi ha detto che in quegli stadi senza tifosi si prova «una sensazione molto spiacevole» e anche Cristiano Ronaldo, a modo suo, con due metafore strane, ha espresso un pensiero del genere: «È come andare al circo e non vedere i clown, come entrare in un giardino senza fiori».
Non è un caso che un disagio simile mi pare sia stato trasmesso dalle immagini del funerale del Principe Philip, con pochissime persone invisibili all’interno della St George’s Chapel, confuse con il legno scuro del coro. Un funerale che sembrava svolto per nessuno veramente, non per i vivi almeno. In modo opposto i cartonati del pubblico, con cui nei primi giorni venivano coperti gli spalti, trasformerebbero la partita in un funerale, come se quelle persone fossero morte. Come se la foto si fosse allargata fino a prendere il posto della lapide, e l’audio finto che alcune tv hanno implementato fosse la loro voce dall’oltretomba. Gli stadi sono diventati, da eco-sistemi architettonici che erano, multi-funzione, tecnologici, semplici rimesse per gli autobus (come quello di Brasilia costruito per il Mondiale del 2014). Ogni tentativo tecnologico ha fallito, anziché avvicinare il pubblico virtuale non ha fatto che aumentare la loro assenza in carne e ossa. Ancora oggi in alcuni stadi c’è una specie di pubblico pixelato, che appare solo nelle inquadrature dall’alto e scompare in quelle dal campo, lasciando i calciatori in mezzo al nulla. Fa venire in mente quei teloni usati per nascondere le impalcature durante i lavori, che replicano la facciata del palazzo in restauro. Sotto a questo palazzo, però, si nascondono travi di cemento grezzo con cavi penzolanti e strutture incompiute.

Insomma non ci siamo riusciti a sostituire il pubblico e, anzi, se c’è una cosa che dovremmo aver imparato in questa stagione pandemica è che non se può fare a meno. È un discorso che prima non era così chiaro, d’accordo, ma che adesso dovrebbe diventare prioritario. Soprattutto per il calcio italiano, che il problema degli stadi vuoti lo aveva anche prima. Anziché chiedersi come conquistare mercati nuovi, o fasce d’età che preferiscono altre forme di intrattenimento, la domande centrale per il nostro calcio dovrebbe essere: come facciamo a far tornare le persone allo stadio? Ma è un discorso che vale per tutti, se è vero che (e dai discorsi fatti sembra quanto meno verosimile) che parlando di Superlega già si fantasticava di partite giocate in continenti lontani con fusi che avrebbero reso difficile la visione anche televisiva ai tifosi delle squadre coinvolte. E chissà che non sia del tutto casuale che questa (tentata) rottura sia arrivata proprio nel momento in cui tifosi, intesi come un attore con un proprio ruolo, che allo stadio non osserva solo ma agisce e parla anche, non erano presenti.
Per la prima volta da dieci mesi si torna a parlare di (poco) pubblico allo stadio, forse già da maggio, e magari sarà anche il momento per iniziare a mettere in discussione l’idea di stadio come posto potenzialmente pericoloso, da tenere sotto controllo col massimo della propria forza e autorità. Come ricettacolo del “peggio”, si diceva che era la violenza a tenere lontane le persone, ma senza violenza, una volta pensate e applicate tutte le misure repressive possibili, le persone non sono tornate allo stadio. Allora, forse, prima di chiedersi come attrarre «le giovani generazioni che si stanno allontanando da questo sport» (Andrea Agnelli sul Corriere dello Sport), ci si dovrebbe fare qualche domanda su cosa ha allontanato quelli che prima dedicavano volentieri non solo un’ora e mezza, ma un intero pomeriggio per andare a vedere alla propria squadra dal vivo, per sentirsi parte di qualcosa che non era solo uno spettacolo audio-visivo. Perché a me sembra siano più o meno le stesse ragioni che molti avevano contro la Superlega (poco equilibrio sportivo ed economico, prezzi che di certo non si sarebbero abbassati, delocalizzazione, disinteresse per la storia dei club e persino dei trofei). E se in bocca a Ceferin, Infantino, John Henry o chi per loro, la frase «il calcio è dei tifosi» è solo retorica, è vero anche che il fallimento della Superlega dimostra che persino molte di quelle 12 squadre di fatto non possono fare a meno dei propri tifosi, di quelli che già amano il calcio e la loro squadra. Senza dimenticare il presupposto di fondo che la stragrande maggioranza dei club, o delle leghe nazionali, non ha un mercato globale come il loro.
fonte ultimouomo.com