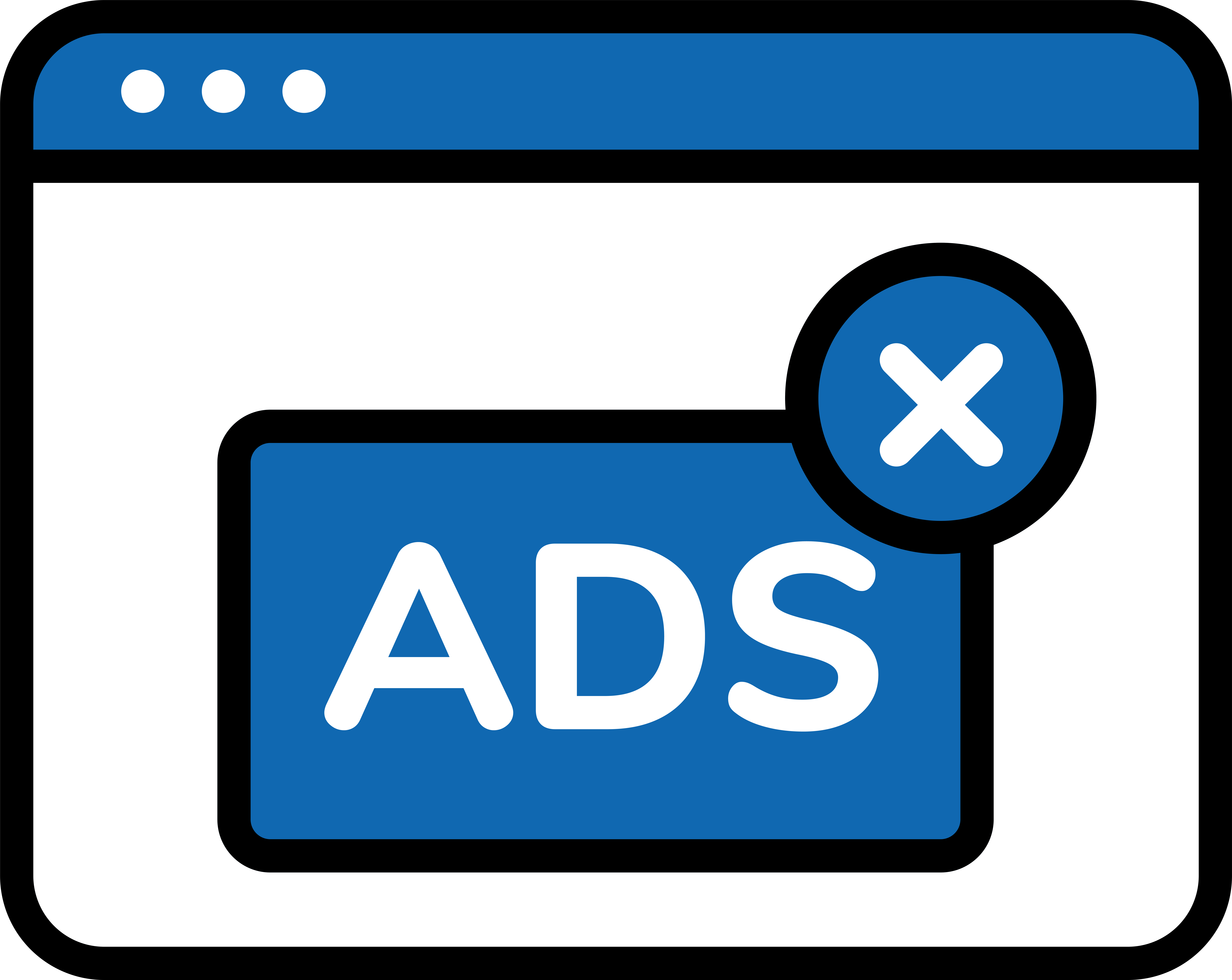«In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente».
Con queste parole, Andrea Agnelli ha annunciato il desiderio di dodici club europei di lanciare una nuova competizione, la Superlega, un torneo a numero chiuso alternativo alla Champions League, fondato su un modello di accesso slegato dai campionati nazionali, che potremmo chiamare per riassumere “all’americana”. Come previsto, le reazioni sono state negative, sia quelle dei tifosi che dei commentatori, ma soprattutto quelle della UEFA e delle leghe nazionali dei club in questione, che hanno minacciato cause e rimozioni dai rispettivi campionati per i club coinvolti in questo progetto di secessione.
Il dibattito rimarrà acceso nelle prossime settimane e il modo nel quale evolverà la situazione nei prossimi mesi è incerto. Molto è già stato scritto negli ultimi anni sulla concentrazione sempre più oligopolistica di ricchezza e talento in pochi squadre europee, e di come questo abbia cambiato il panorama calcistico del continente. Spesso questa storia è raccontata come quella di uno sviluppo inevitabile, legato all’evoluzione della società, dei suoi consumi culturali e di cambiamenti economici strutturali legati alla globalizzazione. Tutte queste chiavi interpretative non sono sbagliate, però tendono a elidere le politiche economiche portate avanti deliberatamente dai club più potenti, sempre in conflitto con un movimento calcistico più ampio, un conflitto basato sulla strategia del ricatto finanziario. Difatti, cosa rappresenta veramente questo annuncio dei dodici club? Un progetto concreto, oppure soltanto una minaccia per ottenere cambiamenti e trarre più benefici dalle competizioni esistenti?
Guardando alla storia del modello economico del calcio europeo, è possibile individuare in quest’ultima offensiva dei club più ricchi la continuazione logica di una politica attuata dalla metà degli anni ’70, sempre fondata sull’idea di ricatto per ottenere concessioni dalle organizzazioni regolatrici del calcio. Come capita spesso con le evoluzioni del capitalismo attraverso i secoli, l’Inghilterra offre un esempio di queste strategie, che raccontano la storia di uno sport che ha intrapreso un cammino pluridecennale verso più disuguaglianza e pratiche monopolistiche, e di cui l’annuncio della Superlega è un risultato di continuità più che un fulmine a ciel sereno.

Il modello inglese
Come in molti altri paesi europei, il movimento calcistico in Inghilterra si costruì con un controllo delle possibilità di profitto offerte dalla partecipazione finanziaria nei club. L’investimento in una squadra offriva a imprenditori un ruolo sociale e politico di punta, e non tanto un’opportunità diretta di accumulazione. David Conn, nel libro The Beautiful Game, racconta che la Football Association (FA) già dagli albori del XX secolo impediva forme di speculazione finanziaria da parte dei proprietari di club: i dividendi distribuiti erano limitati, e il plusvalore generato dalla vendita di un club doveva essere investito in istituzioni municipali o organizzazioni caritative. Il principio di una condivisone equa dei ricavi, già presente nel caso degli incassi dal pubblico allo stadio, fu stabilito con il primo contratto televisivo firmato con la BBC nel 1965, con i fondi spartiti in parti uguali a tutti i 92 club.
Negli anni ’70 e ‘80, una crisi della profittabilità globale nel settore industriale portò a cambiamenti nelle strategie di crescita dei capitalisti del mondo occidentale. I proprietari di Manchester United e Arsenal ne furono gli esempi più palesi. L’impresa nell’industria delle carni della famiglia Edwards, proprietaria dei Red Devils, entrò in crisi e li portò a guardare al calcio come strategia di accumulazione. Martin Edwards, presidente dei Red Devils dal 1980, trovò un modo di imporre maggiore profittabilità e minor condivisione dei ricavi tra le squadre, minacciando già dal 1981 con altri club di lasciare la First Division. David Dein, un broker di materie prime, comprò azioni dell’Arsenal nel 1983 e ne divenne amministratore delegato, per una somma che l’allora presidente del club qualificò di “soldi buttati dalla finestra”. Invece fu un investimento molto lucrativo, da mettere a confronto con l’impresa precedente di Dein, che si occupava della vendita di materie prime ed entrò in crisi lo stesso anno del suo investimento nell’Arsenal.
Gli anni ’80 furono per i club inglesi più ricchi l’inizio di un processo di finanziarizzazione, che con le loro entrate in borsa offrirono nuove opportunità, che però avrebbero potuto essere realizzate solo allentando o rimuovendo le regole che reggevano il calcio inglese. Il ricatto alla secessione continuò quindi per tutto quel decennio, guidato dalle “Big Five” (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton e Tottenham). Questi club ottennero nel 1983 la fine della condivisione degli incassi agli ingressi e, mentre i diritti televisivi passavano da 5,2 milioni di sterline nel 1983 a 44 milioni nel 1988, le “Big Five” minacciarono di nuovo di lasciare la First Division nel 1985, ottenendo un compromesso con la condivisione disuguale dei ricavi televisivi (50% per la prima divisione, 25% per la seconda, e 25% per la terza e la quarta).
Le deregolamentazioni di quegli anni, che riguardavano anche i mercati televisivi, promettevano grandi opportunità lucrative per le “Big Five”, e l’abitudine al compromesso da parte della FA li incoraggiava a chiedere sempre di più. Nel 1990, il British Satellite Broadcasting (BSB) si unì all’impero televisivo di Rupert Murdoch, Sky, per formare BSkyB. Qualche anno dopo, le “Big Five” andarono da BSkyB con il progetto di lasciare la First Division e di creare una nuova lega. Con l’accordo di BSkyB, la FA scese di nuovo a compromesso, accettando però il progetto senza ammendarlo. Quando i diritti televisivi furono venduti per 305 milioni di sterline nel 1992, solo i venti club di questa nuova Premier League si spartirono quei soldi.
Il neoliberismo e il diritto al ricatto
Come dimostra l’esempio della mercificazione del calcio inglese, la minaccia di andarsene era la premessa delle concessioni ottenute dai club più ricchi. Questo è soprattutto l’esempio di una strategia più generale del capitale emersa al contempo nelle politiche neoliberiste in tutto il mondo durante quel periodo storico. Con la maggiore integrazione economica legata alla globalizzazione, la minaccia di uno “sciopero del capitale” è stata tipica dell’Europa degli ultimi quarant’anni. Nel 1983 per esempio, il presidente francese François Mitterrand per queste ragioni dovette rinunciare alle sue riforme socialiste per il quale era stato eletto due anni prima, per istaurare una “svolta dell’austerità”, nuove politiche neoliberiste di deregolamentazione e privatizzazioni.
Lo storico Quinn Slobodian, nel libro Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, descrive questa strategia come parte integrante della filosofia dei teorici del neoliberismo e della sua attuazione politica. L’economista austriaco Friedrich von Hayek, quindi, viene caratterizzato come difensore dei “diritti xenos del capitale”, cioè il diritto di muoversi ovunque passando frontiere e regolamenti, alla ricerca di opportunità migliori. In realtà, la possibilità di partire, il ricatto della fuga, è più potente della fuga stessa, poiché agisce come forza disciplinante delle politiche economiche di uno stato. Come limite al possibile in ambito economico, questa strategia del capitale è stata un grande successo, come si vede spesso nel nostro paese quando vengono invocate forze come “il mercato” o “lo spread” per argomentare l’infattibilità di politiche economiche ugualitarie e della fattibilità invece di politiche regressive.
Anche i liberisti più radicali, quelli che difendono per esempio la creazione di nuove città autonome in mezzo all’oceano—il Seasteading—per evitare tasse e regole statali, ammettono che i loro progetti fantasiosi sono solo una parte del loro lavoro, mentre l’altro è la pressione sui governi per convincerli a scendere a compromessi ed evitare che questi progetti si realizzino. “Bisogna volere il troppo per ottenere il poco”, dichiarava Pier Paolo Pasolini nel 1973, difendendo la radicalità degli esponenti di Lotta Continua. Si dà il caso che questo aforismo sia stato in realtà seguito con grande successo da forze politiche diverse, in un quadro generale di deregolamentazione votata all’accrescimento delle rendite finanziarie legate alla mercificazione del calcio.
Tornando al pallone quindi, questa parentesi generale dimostra che la Superlega si iscrive in un quadro globale di ricatti fatti dagli attori più potenti di settori economici. Nel caso della Superlega, solo i prossimi mesi ci potranno dire se rappresenta un progetto concreto o se è un bluff, una strategia di negoziazione per ottenere maggiori concessioni dalla UEFA nell’organizzazione della nuova Champions League. Al di là del ricatto strettamente finanziario però, esiste anche un ricatto morale. In primo luogo prende la forma della naturalizzazione, cioè di una naturale evoluzione dell’economia calcistica che renderebbe obbligatori questi cambiamenti, seguendo il famoso slogan di Margaret Thatcher—“there is no alternative”. Con questa premessa, il sostegno a questi cambiamenti viene qualificato come progressista, lungimirante, mentre gli oppositori vengono descritti come conservatori, dinosauri sclerotici, difensori nostalgici dello status quo. Su questa rappresentazione ideologica si è costruito lo sgretolamento di un numero di protezioni e controlli statali nel mondo occidentale, ben al di là del calcio.
La Superlega, una novità?
Le tante voci che si sono alzate in questi giorni per criticare il progetto di Superlega hanno tutte rilevato quanto la nozione di lega chiusa, senza promozioni né retrocessioni, rappresenti uno spartiacque nella storia del calcio, l’importazione di un modello di lega sportiva americano. In effetti, rilevare la continuità della Superlega nell’evoluzione calcistica degli ultimi decenni non significa cancellare la differenza fondamentale che questa evoluzione rappresenterebbe. Sarebbe comunque bene notare che anche se, in teoria, qualsiasi squadra può arrivare in Champions League e vincerla, in pratica i successi sportivi nazionali e internazionali sono sempre più concentrati tra i club più ricchi, e la tendenza non sta cambiando, anzi.
«I piccoli club», dichiarava Martin Edwards (il sopraccitato presidente del Manchester United) nel 1985, «ci stanno dissanguando. Per il bene del calcio, devono essere neutralizzati». Un argomento non dissimile da quello portato avanti, su una scala diversa, dai difensori di questa nuova Superlega. Peraltro, un tono non dissimile da quello di Claudio Lotito nel 2015, quando lamentava la presenza di squadre troppo “piccole” in Serie A, dichiarando: «Se mi porti su squadre che non valgono un cazzo… Noi fra due o tre anni non c’abbiamo più una lira». Questi esempi dimostrano che criticare la Superlega non può significare erigere ad esempio una nostalgia per un calcio “di prima”, o sdoganare le élite calcistiche nazionali, che ora si ritrovano vittime di dinamiche che loro stesse hanno imposto a realtà calcistiche inferiori del proprio paese. Gary Neville, peraltro uno dei migliori osservatori del calcio in Inghilterra, è caduto in questa trappola quando domenica si è lanciato in una diatriba contro i proprietari americani dello United, confrontandoli con i valori diversi della sua squadra nei decenni passati.
La realizzazione che la Superlega di Andrea Agnelli e Florentino Perez fa parte integrante di un movimento nel calcio che trova le radici quasi cinquant’anni fa non vuol dire accettare questo nuovo progetto, senza combattere quello che rappresenta nell’accrescimento del divario tra il calcio dei pochi e quello dei tanti. Si spera tra l’altro che gli addetti ai lavori più mediatici di queste squadre, personaggi come Jürgen Klopp o Pep Guardiola per esempio, che non disdegnano l’espressione di opinioni politiche forti su temi importanti, sapranno essere critici del progetto dei loro club. Per colmare davvero questo divario, però, bisogna capire da dove nascono questi progetti, che non sono il frutto di una naturale evoluzione dell’economia sportiva, ma piuttosto il risultato di scelte politiche ben precise che attraversano la storia europea degli ultimi decenni.
fonte ultimouomo.com