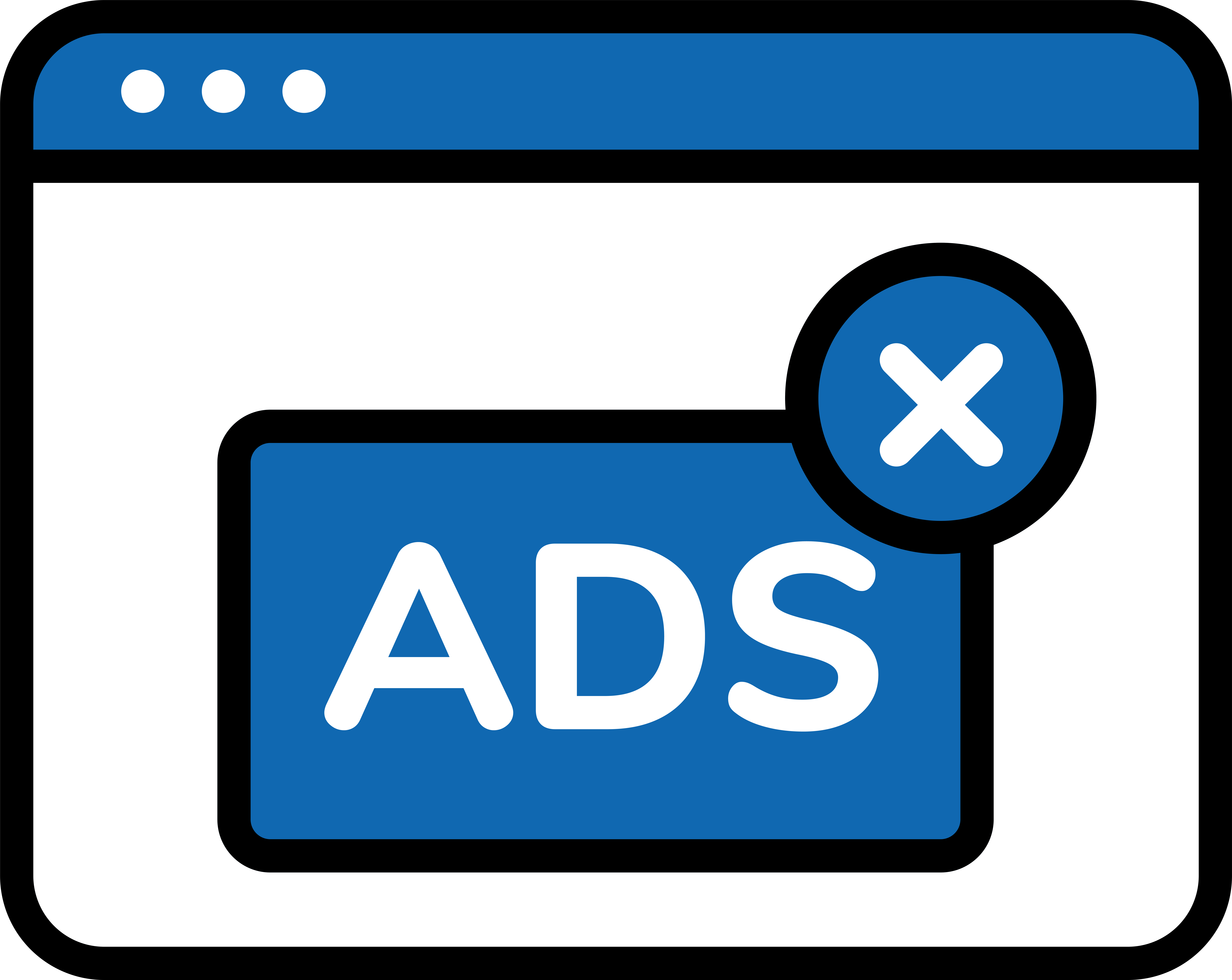La Bailarina
Gli amori impossibili sono quelli che restano per sempre.
Proprio perché incompiuti, tengono un piede nella porta del tempo, facendo in modo che essa non si rischiuda alle spalle.
Ero un ventenne esuberante. Tenevo il mondo nella mano destra e lo lanciavo in alto, riprendendolo con la sinistra. Come tutti i ragazzi di quell’età.
Avevo convinto mio padre a lasciarmi andare a Bergamo per la semifinale di Coppa delle Coppe fra Atalanta e Malines.
La sera prima di partire la trascorsi in un locale di San Sebastian assieme ad Alvaro, un amico che viveva a Hondarribia, poco distante da lì.
In quel locale alla buona si stava esibendo un trio di rock’n roll acrobatico. Il padre cinquantenne in ottima forma, il figlio maggiore e la figlia, forse mia coetanea, leggera come la brezza di primavera.
Aveva il fisico perfetto. Era piccolina. Capelli corvini, raccolti dietro la nuca. Naso leggermente pronunciato. La pelle tenera e le forme plasmate dalla mano di uno scultore.
Me ne innamorai immediatamente, come ci si innamora a vent’anni.
Si chiamava Almudena.
Mi dimenticai subito di Alvaro, che se ne tornò al suo paesino di confine dopo la seconda birra.
Io rimasi a guardarla ballare. Fino alla fine.
Era già notte.
Attraverso il cameriere, che conoscevo per via di un amico comune, le feci arrivare una birra con un biglietto con scritto “sei bellissima”.
Quando capì chi gliel’aveva mandata, venne a sedersi al mio tavolo, con la birra in mano.
Parlammo a lungo. Non ricordo più di che cosa. Ricordo solo che la chiamavo Nena, come se ci conoscessimo da una vita. Perché quell’attimo fu come una vita intera.
Poi, le presi la mano e mi alzai.
“Almudena, è ora di andare.”
La voce arrivò dal fondo del locale.
Nena si alzò in punta di piedi, come fanno le ballerine, e mi diede un bacio sulla guancia. E lasciò che la sua mano scivolasse fuori dalla mia. Con una lentezza eterna.
Il giorno dopo fui a Bergamo per la partita.
Andò come andò.
Arrivai nella mia casa di Pamplona dopo quindici ore di guida.
Mi gettai sul letto vestito. Dormii per dodici ore di fila. O forse di più.
Al risveglio mi sentivo leggero. Assaporavo un retrogusto piacevolmente malinconico. Tenero e profondo. Irraggiungibile. E mi si sovrapponevano i ricordi di Nena e quelli di una qualificazione sfumata.
Lo stesso retrogusto lo provo sempre. Ogni volta che ripenso a quella partita. Ogni volta che ripenso a quella ballerina che non rividi mai più.
Il giorno del quarto di finale contro il PSG ero, per lavoro, in una insignificante cittadina occitana.
La connessione internet dell’hotel era scarsa e non mi riuscì di vedere la partita. Solo fotogrammi con una rotella in mezzo che girava all’infinito.
L’unico ombelico che mi teneva legato alle sorti dell’Atalanta erano i messaggi che el Tio mi mandava sul telefono.
Aggiornamenti telegrafici, ma che lasciavano trasparire i sentimenti di sofferenza di quell’uomo per me imprescindibile.
Soffrivo con lui. O meglio, soffrivo attraverso di lui.
Non riuscii a prendere sonno, quella notte.
Allora, poco dopo le due, pagai il conto e salii in macchina.
Valicai i Pirenei a Roncisvalle che albeggiava.
Abbassai i finestrini e lasciai che entrasse l’ultima frescura della notte.
In sottofondo Almost Blue suonata da Chet Baker.
Pensai alla partita. Alla semifinale che non ci sarebbe stata.
E mi risalì un tenero retrogusto. Malinconicamente gradevole.
Come quella volta del Malines.
Come quella notte con Nena.
Rodrigo Dìaz

Proprio perché incompiuti, tengono un piede nella porta del tempo, facendo in modo che essa non si rischiuda alle spalle.
Ero un ventenne esuberante. Tenevo il mondo nella mano destra e lo lanciavo in alto, riprendendolo con la sinistra. Come tutti i ragazzi di quell’età.
Avevo convinto mio padre a lasciarmi andare a Bergamo per la semifinale di Coppa delle Coppe fra Atalanta e Malines.
La sera prima di partire la trascorsi in un locale di San Sebastian assieme ad Alvaro, un amico che viveva a Hondarribia, poco distante da lì.
In quel locale alla buona si stava esibendo un trio di rock’n roll acrobatico. Il padre cinquantenne in ottima forma, il figlio maggiore e la figlia, forse mia coetanea, leggera come la brezza di primavera.
Aveva il fisico perfetto. Era piccolina. Capelli corvini, raccolti dietro la nuca. Naso leggermente pronunciato. La pelle tenera e le forme plasmate dalla mano di uno scultore.
Me ne innamorai immediatamente, come ci si innamora a vent’anni.
Si chiamava Almudena.
Mi dimenticai subito di Alvaro, che se ne tornò al suo paesino di confine dopo la seconda birra.
Io rimasi a guardarla ballare. Fino alla fine.
Era già notte.
Attraverso il cameriere, che conoscevo per via di un amico comune, le feci arrivare una birra con un biglietto con scritto “sei bellissima”.
Quando capì chi gliel’aveva mandata, venne a sedersi al mio tavolo, con la birra in mano.
Parlammo a lungo. Non ricordo più di che cosa. Ricordo solo che la chiamavo Nena, come se ci conoscessimo da una vita. Perché quell’attimo fu come una vita intera.
Poi, le presi la mano e mi alzai.
“Almudena, è ora di andare.”
La voce arrivò dal fondo del locale.
Nena si alzò in punta di piedi, come fanno le ballerine, e mi diede un bacio sulla guancia. E lasciò che la sua mano scivolasse fuori dalla mia. Con una lentezza eterna.
Il giorno dopo fui a Bergamo per la partita.
Andò come andò.
Arrivai nella mia casa di Pamplona dopo quindici ore di guida.
Mi gettai sul letto vestito. Dormii per dodici ore di fila. O forse di più.
Al risveglio mi sentivo leggero. Assaporavo un retrogusto piacevolmente malinconico. Tenero e profondo. Irraggiungibile. E mi si sovrapponevano i ricordi di Nena e quelli di una qualificazione sfumata.
Lo stesso retrogusto lo provo sempre. Ogni volta che ripenso a quella partita. Ogni volta che ripenso a quella ballerina che non rividi mai più.
Il giorno del quarto di finale contro il PSG ero, per lavoro, in una insignificante cittadina occitana.
La connessione internet dell’hotel era scarsa e non mi riuscì di vedere la partita. Solo fotogrammi con una rotella in mezzo che girava all’infinito.
L’unico ombelico che mi teneva legato alle sorti dell’Atalanta erano i messaggi che el Tio mi mandava sul telefono.
Aggiornamenti telegrafici, ma che lasciavano trasparire i sentimenti di sofferenza di quell’uomo per me imprescindibile.
Soffrivo con lui. O meglio, soffrivo attraverso di lui.
Non riuscii a prendere sonno, quella notte.
Allora, poco dopo le due, pagai il conto e salii in macchina.
Valicai i Pirenei a Roncisvalle che albeggiava.
Abbassai i finestrini e lasciai che entrasse l’ultima frescura della notte.
In sottofondo Almost Blue suonata da Chet Baker.
Pensai alla partita. Alla semifinale che non ci sarebbe stata.
E mi risalì un tenero retrogusto. Malinconicamente gradevole.
Come quella volta del Malines.
Come quella notte con Nena.
Rodrigo Dìaz

By staff