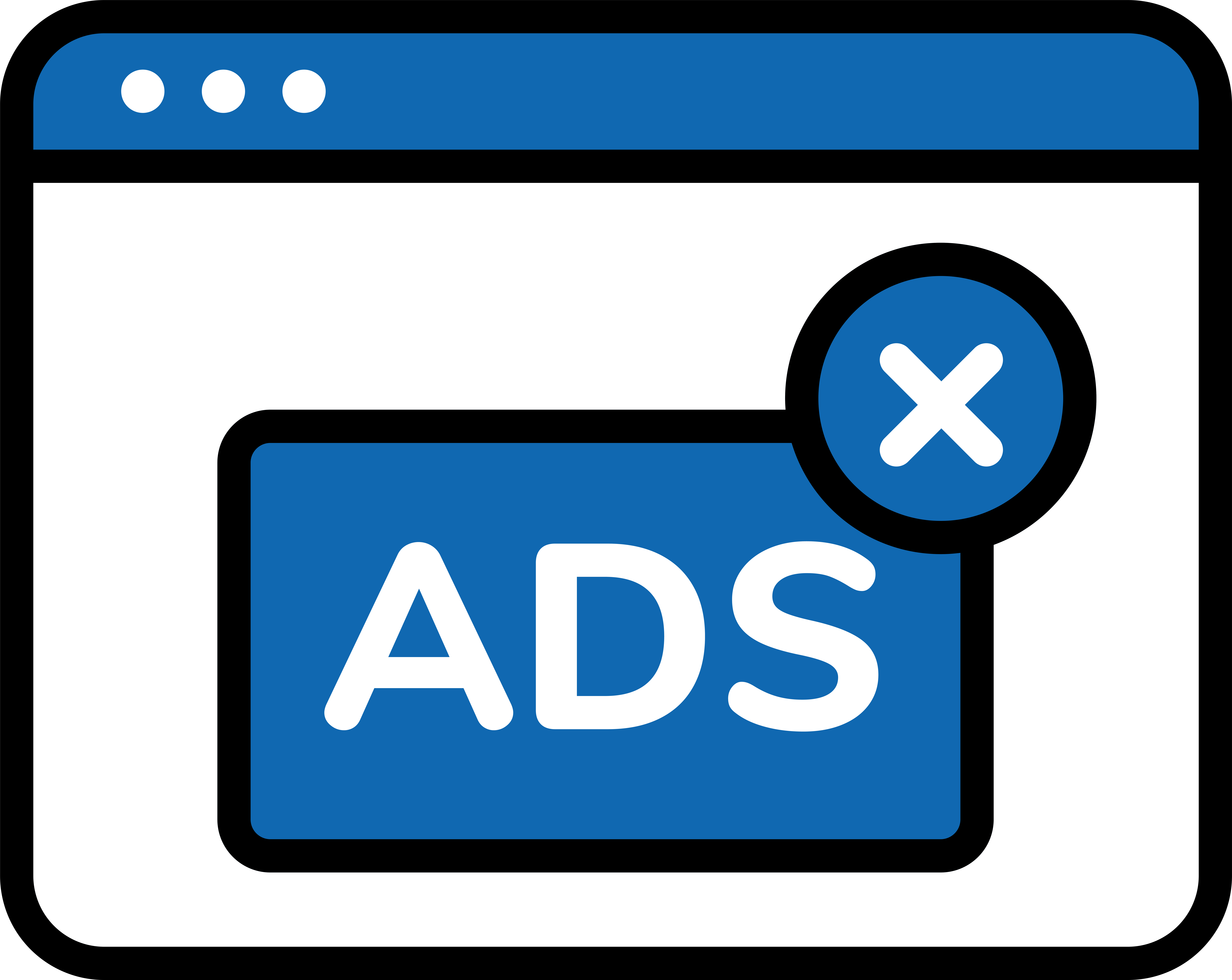MOLA MIA
Ho paura. Tanta paura.
Recluso dentro la manciata di metri quadri della mia casa, dovrei sentirmi al sicuro. Ma non lo sono.
Forse perché non ho mai vissuto la mia piccola casa come un rifugio per la notte, bensì come una piazzola di sosta. Un punto intermedio fra quello che avevo fatto e quello che avrei dovuto fare. Un distributore dove fare rifornimento.
Viverci dentro, senza poter uscire, mi ha messo al riparo, forse, da quel nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Che sta mettendo crudelmente a dura prova la resilienza di Bergamo.
Forse, il virus qui dentro non riuscirà ad entrare. Ma la paura lo ha già fatto.
E’ entrata un passo avanti a me.
O, forse, era già dentro. Seduta sul divano ad aspettarmi.
Dolce. Gentile. Tenera come un amante.
Mi prepara la colazione. Il pranzo. E poi anche la cena.
Non mi lascia solo. Nemmeno per un istante.
Non fa rumore. Non parla. Non mi disturba. Ma è sempre lì. Come il cane Ernesto con il Tio.
Non ho paura per me, s’intenda.
La paura per sé stessi la si può vincere. La si può combattere. Tutt’al più la si può esorcizzare.
E’ la paura per gli altri, quella che non si può battere. Non la si riesce ad allontanare. Non la si riesce a scacciare. Come le zanzare, quando ronzano attorno.
La paura è un diritto. Spesso anche un dovere. A volte un incarico.
Ho paura per il Tio.
Quell’uomo robusto, silenzioso, arcigno, mi era sempre sembrato invincibile. Come lo è un padre per un bambino.
Lui è parte di quella generazione che non dovrebbe morire mai. Che ritieni irraggiungibile. Forse impareggiabile.
Nonostante il ginocchio a pezzi, ero sempre stato convinto che avrebbe potuto giocare a calcio fino a cinquant’anni.
Fino a quel giorno, qualche anno fa, che sua sorella Pilar e Miguel Angel, suo marito, lo portarono in ospedale per la brutta tosse che lo attanagliava da settimane.
Polmonite. In ospedale ci rimase per quasi un mese. Passò anche dalla terapia intensiva.
Da quel giorno, i suoi polmoni sono rimasti deboli come quelli di un passerotto.
Ho paura per il Tio.
Lo chiamo, ogni tanto. Non troppo spesso per non trasferirgli la mia paura. Non troppo di rado, per non lasciarlo solo.
Andrei da lui. Anche solo per portargli la spesa. Ma non mi perdonerei per tutta la vita di poter essere il veicolo del killer.
Ho paura per il Tio.
E quando questa paura mi fa tremare le braccia, mi stringe gli occhi, mi rimbecillisce le gambe, allora mi guardo i cento gol dell’Atalanta dello scorso anno.
Tra un bicchiere di orujo de hierba, di cui mi rendo conto di abusare, e uno di Cesilla, mi guardo i gol di Ilicic. I tunnel del Papu. Le sgroppate di Gosens. Quelle di Hateboer. Le rasoiate di Muriel. E le sportellate di Palomino, sostituendo la sua faccia dagli zigomi decisi con quella altrettanto spigolosa del Tio. Sostituendo le sue gambe da cavaliere delle Pampas con quelle dai calzettoni abbassati del Tio.
Dalla mia finestra non vedo la via che porta al Hospital de Navarra. Nemmeno a quella che conduce alla Clinica Universidad de Navarra.
Però, in lontananza, il rumore delle ambulanze lo si può cogliere. Soprattutto la sera.
Allora, tendo l’orecchio.
Cerco di capire se arriva dal centro della città o dalla periferia, dalla parte di Villava, dove c’è la sua cascina.
Chiudo gli occhi e mi concentro. E sfido la realtà, convincendomi che no, non arriva da Villava.
E quando succede, come qualche istante fa, che nemmeno la mia cocciutaggine e la mia voglia adolescenziale di deviare la realtà riesce a convincermi che la sirena dell’ambulanza arriva dalla città, allora lo chiamo.
“Sono io.”
“Non avevo dubbi.”
“Come va? Ti serve qualcosa? Il Ramòn Bilbao ce l’hai?”
“Hai sentito un'altra ambulanza.”
E non era una domanda.
Cercavo di farlo parlare. Per tentare di comprendere il suo respiro. Tenevo l’orecchio appiccicato al ricevitore, per scoprire se anche il minimo rantolo usciva assieme alla voce del Tio. Per convincermi che no, non era malato.
Ma far parlare il Tio non è mai facile. Soprattutto quando è triste. E in questo momento nessuno può non essere triste.
“Mola mia.”
“Cos’hai detto, Tio?”
“L’ho sentito in qualche video. E’ il motto dei tuoi amici bergamaschi.”
Ecco, questa è la generazione che stiamo perdendo. La generazione che il virus sta abbattendo come fossero mosche. La generazione più attaccata dall’infame.
Eppure è la generazione che non ha paura. La generazione che ci sta insegnando la forza di non mollare.
E lo fa soltanto per non farci preoccupare. Per proteggerci. Almeno, per proteggere il nostro spirito.
“La “o” un po’ più chiusa, Tio.”
“Va bene. Un po’ più chiusa. Mola mia.”
Rodrigo Dìaz