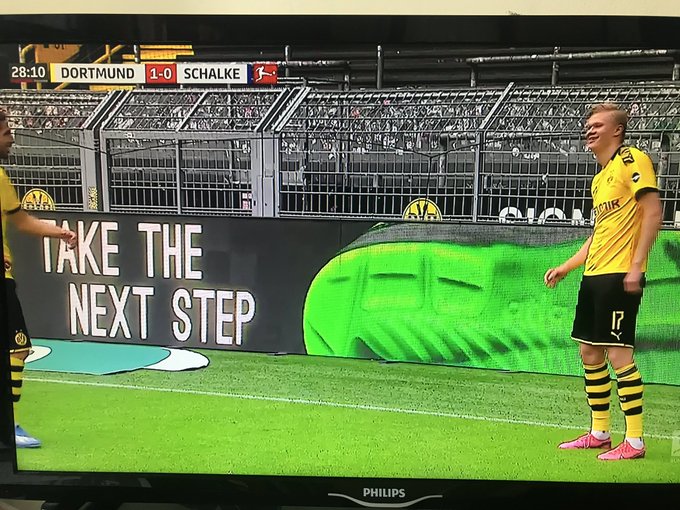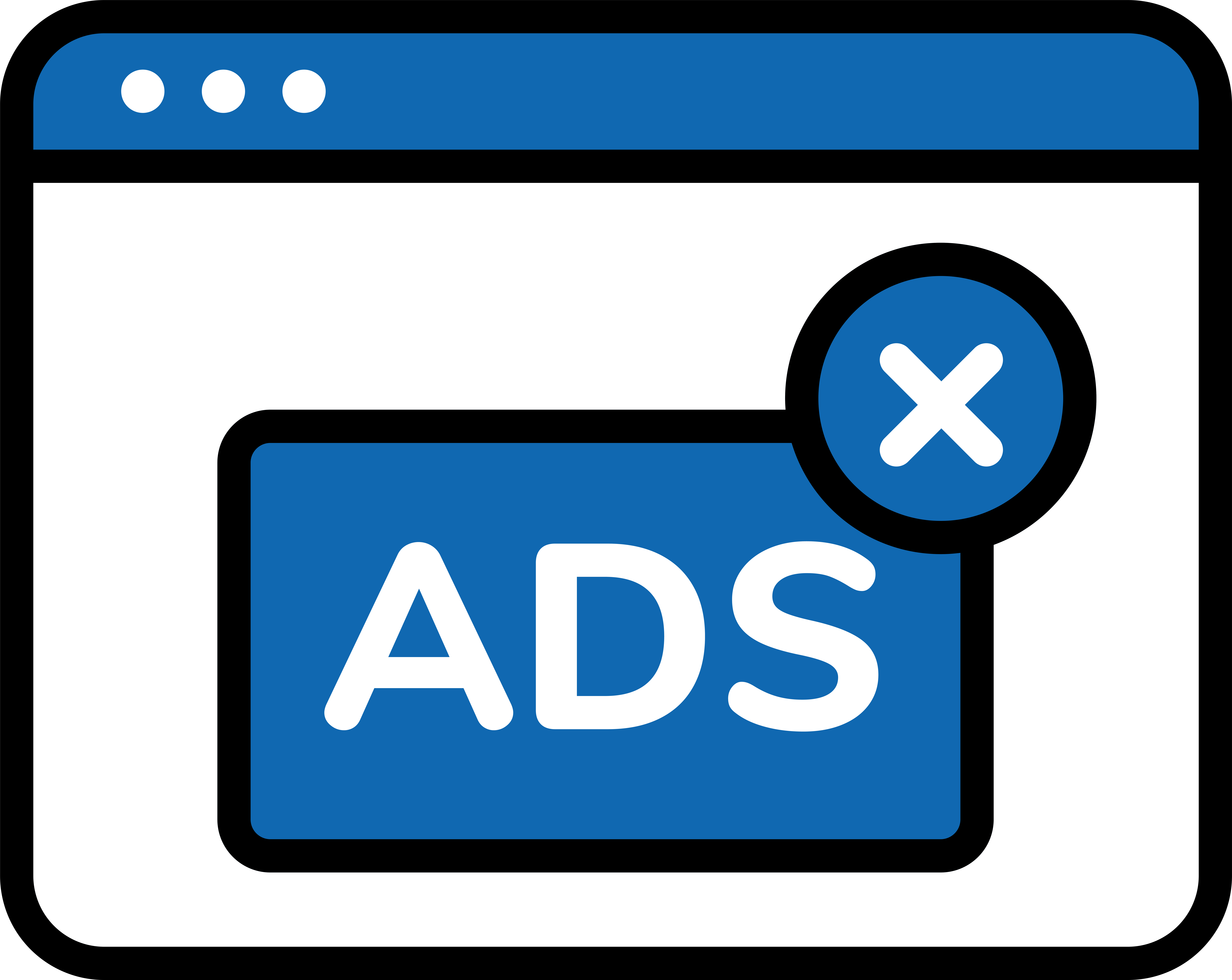Sulla ripresa del calcio ci stiamo facendo le domande sbagliate

Non si può tornare a giocare a ogni costo, ma nemmeno tifare per il fallimento.
Dopo mezz’ora dall’inizio della partita tra Borussia Dortmund e Schalke 04, Erling Haaland ha segnato un gol a suo modo «storico». Anche piuttosto bello, con una palla di Piszczek per Brandt che di prima, con un tocco di tacco-esterno, mette Thorgan Hazard in condizione di crossare basso tra difesa e portiere, dove Haaland è arrivato sulla palla come uno di quegli squali che sbucano da sotto la schiuma del mare e inghiottiscono un gabbiano.
Ma è stato un gol «storico» non per la sua qualità, o perché si trattava del tredicesimo di Haaland in dodici partite con la squadra tedesca, quanto piuttosto perché era il primo successivo all’interruzione dei principali campionati e tornei di calcio professionistici, dovuta al diffondersi del Covid-19. Il primo gol di un calcio nuovo, che si gioca con palloni disinfettati e stadi senza pubblico, con ancora in corso la pandemia di un virus per cui non esiste vaccino o cura efficace.
E la situazione sarebbe stata surreale anche se Haaland non avesse esulato correndo fino alla bandierina del calcio d’angolo, girandosi verso i suoi compagni «a distanza» e ballando sul posto. Così come non c’era bisogno di festeggiare la vittoria netta (4-0) nel derby della Ruhr sotto gli spalti privi di tifosi, davanti a quel muro giallo che adesso è un muro e basta, per sottolineare ed esasperare la separazione che c’è oggi tra il calcio d’élite e i tifosi.
Sono immagini che vanno al di là del significato che volevano dargli Haaland e il Borussia Dortmund. Volevano essere ironici? O addirittura critici nei confronti della ripresa in queste condizioni? (A qualcuno il balletto di Haaland ha ricordato il meme della «coffin dance», il che aggiunge uno strato dark all’esultanza). In un certo senso non importa perché ognuno interpreta sulla base delle convinzioni che aveva in precedenza.
Chi era felice di poter guardare una partita di calcio dopo tanto tempo non ci ha visto niente di male; mentre la voce più grossa, mi pare, l’ha fatta chi ci ha visto l’ennesima ipocrisia di un sistema corrotto, come i giocatori che appena sostituiti ricevono la mascherina mentre quelli in campo sono liberi di scambiarsi i rispettivi aerosol. Ah quindi sui calci d’angolo si sudano letteralmente addosso e il gol lo festeggiano mantenendo il distanziamento sociale?
Se questo è calcio
In un articolo scritto il 5 marzo, mentre in Italia ancora si giocava, seppur a porte chiuse, mi chiedevo che senso avesse giocare in stadi senza tifosi e trasmettere partite in tv mentre molte attività erano chiuse e morivano più di cento persone al giorno (che presto sarebbero diventate mille). Adesso il clima emotivo è completamente diverso, molte misure restrittive sono già cadute, altre cadranno nelle prossime settimane, anche se non sembra esserci una strategia di ampio respiro per tenere il virus sotto controllo e continuano a morire parecchie persone ogni giorno (più o meno lo stesso numero di persone che moriva il 5 marzo). Hanno riaperto bar e ristoranti, stanno per farlo addirittura le palestre e le frontiere nazionali. E in un contesto del genere, sembra sempre più verosimile che l’Italia segua l’esempio della Germania.
Il presupposto, però, è che non ci sarebbero le condizioni sanitarie per ricominciare a giocare a calcio – come non ci sarebbero per molte altre cose, considerando che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ammesso, in un’intervista a La Stampa, di aver accelerato le riaperture «contro il parere degli scienziati».
Ma non ci sono neanche in Germania, dove la situazione sanitaria è migliore della nostra. In fondo è proprio la deroga concessa al calcio sulla «distanza interpersonale» che lo mostra. Molte delle misure necessarie sono facilmente applicabili in un’organizzazione ricca e complessa come una società di calcio professionistica: pulizie e sanificazione di spogliatoi e palestre, prodotti specifici e procedure per l’igiene personale, termoscanner e organizzazione degli ingressi e delle uscite differenziate dai luoghi di lavoro. Ma la distanza tra calciatori non può essere controllata.
Così come è problematica l’eventuale gestione dei casi postivi. In attesa di un protocollo ufficiale, sembra che in Italia l’intenzione sia quella di isolare l’intera squadra nel caso in cui un calciatore risulti positivo, mentre in Germania hanno capito che in questo modo si rischia di rimandare solo un’eventuale chiusura definitiva del campionato. Quindi, anche in caso un giocatore di Borussia o Schalke, tanto per fare un esempio, risulti positivo nei prossimi giorni il protocollo della Bundesliga (a cui si sta ispirando quello inglese) prevede che venga isolato solo lui. È un’altra deroga a quella misura di «tracciamento» e isolamento dei contatti che in teoria è necessaria per contenere il virus – e per cui in Italia, in pratica, non c’è ancora una strategia convincente neanche al di là del calcio: se in un’azienda viene trovato un lavoratore positivo al Covid-19, ad esempio, non è richiesto che l’azienda chiuda e isoli tutti i dipendenti, ma dovrebbe essere l’autorità sanitaria a risalire ai cosidetti «contatti stretti» e a disporre eventuali provvedimenti di isolamento.
(In realtà, anche in Germania ad avere l’ultima parola sono le autorità sanitarie locali dei vari Lander: per questo il Dresda, con due giocatori positivi al tampone, è stato messo interamente in quarantena per due settimane, prima ancora che il campionato di seconda divisione ricominciasse. Con due partite già saltate, Christian Seifert, CEO della Federazione tedesca, ha detto che «non cambia l’obiettivo», cioè finire la stagione, «ma solo i piani». Vedremo.)
Non è un segreto che si tratti di un «tentativo», magari destinato a naufragare, per non far fallire i club e che non è detto basterà: secondo gli analisti della Deutsch Bank i 20 club europei più ricchi (quelli più ricchi ma anche con stipendi più costosi) rischiano di perdere nel migliore dei casi il 18% del proprio fatturato, nel peggiore il 48%.
In questa situazione limite, che non avevamo mai vissuto, la frattura tra il mondo del calcio e una parte consistente degli appassionati italiani è aumentata. Forse anche perché si è parlato di ricominciare a giocare quando i morti per questa pandemia nel nostro Paese erano diverse centinaia al giorno, ma mi sembra che oggi la distanza sia incolmabile tra chi dice che il campionato deve riprendere a tutti i costi e chi invece tifa per il «botto», il «tonfo», insomma per una crisi da cui non ci sia possibilità di tornare indietro.
Il problema è che nessuna delle due posizioni vede quanto ci sia di vero nell’altra.
Tifare per il fallimento
Interrogato a proposito dalla BBC, Jurgen Klopp ha ricordato che in fondo tutti i calciatori e gli allenatori hanno cominciato in stadi vuoti, senza un gran numero di tifosi a sostenerli, e che il calcio è bello anche così. È la stessa retorica della «purezza» che si morde la coda. Se i tifosi per cui il calcio è un rito, con un valore sociale e identitario, accusano il sistema professionistico di pensare solo alla propria sopravvivenza, allo stesso modo si può accusare quei tifosi di pensare solo a se stessi.
Il punto principale su cui sembra esserci un fraintendimento è che nessuno pensa che le condizioni attuali siano ideali (in Germania queste partite sono chiamate «Geisterspiele», cioè «partita fantasma»). Anche chi non ha pubblicato un post su Facebook con affiancate le foto dei giocatori abbracciati sui corner e quelle dei panchinari con la mascherina distanziati come elementi di un’opera d’arte minimale, si è accorto del contrasto. Abbiamo avuti tutti delle sensazioni contrastanti guardando Borussia-Schalke e se l’intenzione è quella di sostituire il tifo organizzato di certo la soluzione non sono le bambole gonfiabili.
Ma la stanchezza nei confronti di questo calcio non riguarda solo gli ultras (tipo quelli granata che qualche giorno fa hanno esposto lo striscione «Migliaia di morti in ogni città / Ma voi pensate alla ripresa della Serie A») che per comodità vengono etichettati come una «frangia estrema» ma in realtà sono i primi, se non gli unici, a impegnarsi per fare solidarietà in casi di questo tipo. Sono anche normali appassionati, collezionisti di sciarpe e maglie, che comprano scarpini e giocano fino a cinquant’anni con gli amici, che sono stufi di quello che viene percepito come un animale morente che sta solamente provando a salvare la propria pelle.
È vero: il calcio riprende per ragioni economiche, come tutto il resto d’altra parte, ed è disposto ai compromessi più assurdi per sopravvivere, compreso quello di rinunciare al tifo dal vivo, diventando uno spettacolo esclusivamente televisivo. Ma non è conveniente, almeno per ora, e l’idea è quella di tornare – quando non può saperlo nessuno – a qualcosa che possa quanto meno avvicinarsi alla normalità. Sicuramente a qualcuno non piacerà, il calcio perderà altri tifosi oltre a quelli che aveva perso negli ultimi anni, ma non sarebbe meglio, per noi, negoziare qualche cambiamento in vista del ritorno del pubblico anziché sperare in un ulteriore impoverimento del calcio italiano?
Quello che non capisco, perché è un sottinteso che non viene mai esplicitato, è che tipo di calcio abbia in mente chi detesta così tanto quello attuale da voler vedere fallire persino la propria squadra. Temo che almeno alcuni abbiano in mente un calcio del passato, magari quello degli anni novanta, che corrisponde al calcio della loro infanzia o gioventù. Un calcio che però era ancora più indebitato di quello attuale. Ma anche quello dei decenni precedenti, o addirittura quello delle serie minori (che ho frequentato per quasi quindici anni), non è un calcio poi così «puro»: anche lì ci sono disuguaglianze, ipocrisia e corruzione.
Il rischio è quello di appiattirsi sulla retorica dei calciatori ricchi e viziati che non tiene conto – oltre che di quei professionisti che lavorano nel mondo del calcio e che sono tutto tranne che ricchi – del fatto che il calcio del 2020 è frutto di trent’anni di investimenti e di innovazioni tecnologiche che hanno professionalizzato giocatori e membri dello staff, alzando il livello medio degli atleti che ne fanno parte, permettendo a quelli con il livello più alto di emergere in misura maggiore rispetto a quanto avveniva in passato.
Certo non è un sistema privo di problemi (adesso ci arrivo) né di certo è il migliore possibile come invece vorrebbe la retorica opposta, ma non si può neanche pensare di passare con leggerezza la spugna su una parte così grande della storia di questo sport. Una delle conseguenze, anziché il ritorno a un calcio arcadico, potrebbe essere quella di un’estremizzazione delle tendenze peggiori del calcio odierno. Perché se tutti i club avranno problemi ne usciranno senza dubbio meglio quelli di prima fascia, mentre spariranno migliaia di società delle serie minori.
E le conseguenze di un eventuale fallimento del calcio italiano ricadranno anche su altre federazioni cosiddette minori, sicuramente per introiti e numero di spettatori. Perché se è vero che il calcio non produce neanche lontanamente il 7% del PIL, è anche vero che è dai suoi introiti e dalle sue tasse che altri sport si finanziano (cosa di cui il ministro Spadafora è consapevole). Quindi, d’accordo, bisognerebbe parlare anche di come far ripartire gli altri sport, ma quando si parla di calcio in parte è in gioco anche la loro sopravvivenza.
Anziché farne un discorso esclusivamente morale o di principio, non si sarebbe potuto utilizzare questo periodo per chiedere quelle riforme che, in quanto spettatori, abbiamo tutto il diritto di chiedere? Ad esempio, non si sarebbe potuto chiedere che dopo questo periodo a porte chiuse si ripartisse davvero con biglietti a prezzi popolari? Oppure non si sarebbe potuta portare avanti la battaglia contro le misure restrittive e di controllo nei confronti dei tifosi, contro il daspo sempre più esteso e potente, assegnato senza processo e senza giudice anche per infrazioni non violente? Contro l’obbligo di comunicare nei giorni precedenti alla partita gli striscioni? Queste non sono cose che ci riguardano tutti, battaglie legali che dovrebbero avere un rilievo maggiore rispetto alle «automobili dei calciatori»?
Ripartire fregandosene di tutto
In ogni caso, l’allontanamento tra il calcio italiano e quella base di tifosi che dovrebbe essere la più fedele e appassionata, e che paradossalmente oggi vuole guardare la propria squadra bruciare insieme al resto, è un processo in corso da tempo. Il coronavirus, proprio come ha fatto in altri ambiti della nostra società, non ha fatto che accelerare le cose e la responsabilità maggiore della situazione attuale va al sistema calcistico, che non ha sfruttato questi due mesi per fare nessuna riflessione più generale. Se il pubblico si è allontanato è anche per il disinteresse mostrato dal sistema-calcio nei confronti delle loro richieste.
Uno dei mantra più ripetuti fino a qualche settimana fa riguardava il «ripensamento» necessario di molte cose che già non funzionavano prima e che l’emergenza aveva portato al proprio limite strutturale. In questo senso, il calcio è una fedele rappresentazione della difficoltà della nostra società a immaginarsi diversamente da come era. Così come non si può fare finta che non esistano persone che lavorano nel calcio senza essere calciatori o dirigenti, sarebbe ingiusto usarli come ostaggio per non aprire neanche una discussione: non si può ripartire con grandi sforzi e sacrifici solo per mantenere in piedi un sistema che in piedi da solo non riesce a starci.
In fondo chi ha voglia di vedere una competizione in cui vincono sempre gli stessi, in cui il divario tra i più forti e quelli meno – neanche i più deboli – è sempre più profondo, e che per di più è poco sostenibile finanziariamente, sempre sull’orlo della crisi? Chi vuole sostenere uno sport che si vede esclusivamente come industria, che ha rinunciato al proprio valore sociale per dedicarsi anima e corpo all’intrattenimento, alla produzione di contenuti, al marketing e al commercio?
La musica sparata a tutto volume negli stadi non potrà mai rimpiazzare i cori di tifoserie orgogliose della propria tradizione e, allo stesso modo, non c’è social network che possa colmare la distanza tra il pubblico e i calciatori se questi ultimi sono ridotti a prodotti finanziari oppure, nel migliore dei casi, in brand viventi. Non ci può essere immedesimazione né partecipazione se non si vive nello stesso mondo, se non si condividono gli stessi valori.
La crisi costringe una razionalizzazione, perché le risorse che si avevano prima non sono più disponibili. Il sistema italiano dovrà rinunciare ad alcune abitudini e aggiornarsi in cose come lo scouting e i settori giovanili. Tanto vale che cominci a ripensare al rapporto con i propri tifosi. Proprio negli anni in cui i fatturati e i valori dei calciatori crescevano, ai tifosi – soprattutto a quelli italiani – restava sempre di meno, andare allo stadio è diventata un’esperienza sempre più complicata, all’interno di stadi italiani che non sono riusciti a rinnovarsi come quelli di altri paesi. Il paradosso è che persino oggi sono loro a pagare gli effetti più immediati di questa crisi, accettando intanto di non andare allo stadio, accettando le esultanze a distanza e l’atmosfera da sala operatoria. Più avanti magari vedendo i propri giocatori migliori andarsene, se non ci rimmeteremo tutti insieme vedendo fallire l’intero sistema.
Alla fine ci resteranno i filtranti di tacco di giocatori come Brandt, la ferocia di Haaland. Certo, di quelli saremo sempre innamorati. Che importa in che Paese giochino, se sono circondati da esseri umani o da ologrammi. Se dopo il gol il pallone verrà disinfettato mentre nella farmacia vicino casa saranno terminate le scorte di gel per le mani. In compenso, chissà, una parte di noi potrà guardare guardare la partita da bordo campo con la realtà virtuale e ritrovarsi in mezzo ai calciatori che esultano. A quel punto, magari, l’unica cosa che potranno abbracciare dopo un gol saranno proprio i nostri fantasmi.
fonte ultimouomo.com